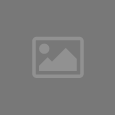Più di ottocento milioni di indiani hanno rinnovato in maggio i 543 deputati della Camera Bassa, sancendo la vittoria dei nazionalisti Indù e la sconfitta del Partito del Congresso di Sonia Gandhi.
Come si sa, l’India è una federazione (ma, come la Svizzera, si chiama Confederazione) con ventinove stati e ventidue lingue ufficiali e molte religioni ed etnie, con un sistema in parte simile a quello dell’Unione europea che ha ventotto stati (destinati ad aumentare), ventiquattro lingue, molte etnie e religioni. Chiamati alle urne nello stesso mese, due ampi corpi elettorali transnazionali “uniti nella diversità” sono la più forte dimostrazione che l’idea di rafforzare la dimensione democratica dell’Unione in una logica federale è costituzionalmente e storicamente possibile e che tale modello può essere preso in considerazione in una riforma delle Nazioni Unite fondata su un insieme di organizzazioni regionali.
India e Unione europea rappresentano in effetto nel mondo due modelli di unificazione con molti aspetti positivi comuni ma forti problematiche dissimili, dotati di assemblee legislative sopranazionali elette a suffragio universale e diretto senza paragone rispetto ad altre forme di integrazione regionale (Mercosur, Unione Africana, ASEM, Nafta…) che sono ancora prigioniere del mito della sovranità nazionale e non hanno ancora scelto per se stesse una finalità o vocazione federale.
I cittadini dell’Unione europea hanno eletto per l’ottava volta dal 1979 il Parlamento europeo all’interno di uno spazio comune abitato da 508 milioni di persone (cui varrebbe la pena di aggiungere i residenti non comunitari) e 388 milioni di elettori e dunque con il secondo corpo elettorale del mondo (se si esclude naturalmente la Cina popolare).
Nelle elezioni dal 22 al 25 maggio, il 43,2 per cento degli elettori ha esercitato il diritto di voto e si sono quindi recati alle urne oltre centosettanta milioni di cittadini scegliendo fra candidati di quattrocento liste o partiti nazionali per eleggere 751 deputati europei.
Sono state le prime elezioni europee dopo due eventi essenziali per la vita dell’Unione: l’onda lunga della crisi finanziaria scoppiata già prima delle elezioni del 2009 ma i cui effetti politici, economici e sociali sono apparsi evidenti solo alla fine del 2009 e le conseguenze sul sistema europeo dell’entrata in vigore – il 1° dicembre 2009 – del Trattato di Lisbona.
Nel primo caso, la crisi ha travolto tredici governi nazionali, portando al potere nuove e talvolta inedite coalizioni, rendendo inevitabile la formazione di accordi governativi fondati su larghe intese. L’insieme degli Esecutivi nazionali è stato costretto a incamminarsi sulla strada stretta e socialmente dirompente di drastiche riforme interne, con un aggiornamento delle regole stabilite a Lisbona, che erano state considerate immutabili per un lungo numero di anni, o attraverso nuovi vincoli a trattato costante o modificando il Trattato o infine adottando un accordo internazionale al di fuori del Trattato.
Si è creato così un nuovo sistema di costituzione materiale con una prevalenza della dimensione intergovernativa, il rafforzamento dei poteri di controllo della Commissione e l’esautoramento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.
Per chi segue con l’occhio dello studioso di costituzioni nazionali o con l’interesse di un attore della politica e dell’economia l’evoluzione dei sistemi costituzionali nazionali dove la democrazia parlamentare post-bellica radicata in tutti i paesi occidentali (con la sola eccezione della Francia) è stata sostituita dalla democrazia degli esecutivi, il concentramento dei poteri nelle mani del Consiglio europeo non è sorprendente.
A livello nazionale, la maggiore efficacia nell’azione dell’Esecutivo – per sottrarlo all’eccessiva e talvolta contraddittoria ingerenza dei parlamenti – è apparsa a molti come il male minore di fronte al groviglio dei problemi da risolvere essendo fondata sui principi della legittimità democratica in entrata e in uscita.
A livello europeo, al contrario, il potere concentrato nelle mani di molti governi si trasforma in anarchia o nel prevalere della logica del più forte o del direttorio di un nucleo di paesi a scapito dell’efficacia e della democrazia.
Dal punto di vista del sistema dell’Unione europea (largamente sconosciuto alle opinioni pubbliche nazionali e sottovalutato da media e mondo politico), le modifiche introdotte dopo negoziati e procedure di ratifica prolungatisi per almeno sette anni (2002-2009) – completando le revisioni introdotte con Maastricht, Amsterdam e Nizza – hanno innovato rispetto ai trattati precedenti su questioni rilevanti che sarebbe stato opportuno far conoscere in campagna elettorale.
Si tratta dell’estensione dei poteri legislativi del Parlamento europeo, del rafforzamento del suo controllo politico sulla Commissione e dell’attribuzione all’Assemblea di un diritto di veto come l’adesione all’Unione o la recessione dall’Unione, gli accordi internazionali, il quadro finanziario pluriennale e l’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata.
L’innovazione potenzialmente più destabilizzante di un sistema a metà strada fra il modello di Vestfalia (la prevalenza degli Stati nazionali) e il modello di Westminster è tuttavia legata alla procedura di nomina della Commissione .
Già al tempo del Progetto Spinelli, il tema dei rapporti tra Parlamento e Commissione era stato oggetto di forti controversie. Vi era chi proponeva un modello svizzero con l’elezione congiunta da parte del Parlamento e del Consiglio per garantire le prerogative dei governi e svincolare l’esecutivo dal controllo di una maggioranza parlamentare, chi suggeriva di introdurre il solo livello della legittimazione parlamentare escludendo i governi e chi infine suggeriva un modello semipresidenziale con l’elezione diretta del Presidente dell’Unione.
La soluzione adottata ha ispirato il modello adottato poi a Lisbona con la designazione del Presidente da parte del Consiglio europeo e l’investitura parlamentare (“voto di fiducia”) dell’intero collegio. La differenza rilevante del Progetto Spinelli rispetto a Lisbona risiedeva nel potere esclusivo del Presidente di scegliere i membri della Commissione determinandone anche il numero.
La Convenzione sulla costituzione europea aveva preso in esame la possibilità dell’elezione diretta del Presidente della Commissione facendone il vero presidente dell’Unione, una soluzione scartata perché considerata prematura così come vennero scartate anche le proposte franco-tedesco legate a una visione intergovernativa.
Il modello finale prevede la designazione del Presidente da parte del Consiglio europeo a maggioranza qualificata secondo la ripartizione dei voti che rimarrà in vigore fino al 1° novembre 2014 o fino al 31 marzo 2017 se richiesto da un governo. Ciò vuol dire attribuire un potere di veto a una minoranza di blocco dei grandi paesi (Francia, Italia, Germania, Regno Unito) contro i piccoli e medi membri, dei paesi del Sud contro quelli del Nord o dei paesi del Nord contro quelli del Sud, dei paesi della nuova Europa contro la vecchia Europa ma anche l’impossibilità per i paesi cosiddetti “out” (Regno Unito, Danimarca e Svezia) di esercitare questo potere di minoranza anche se a essi si unisse un paese con una prevalente posizione nazionalista come l’Ungheria.
La designazione del Consiglio europeo deve essere fatta “tenendo conto delle elezioni europee” e “fatte le appropriate consultazioni” (che, in mancanza di un accordo interistituzionale di applicazione, vuol dire dialogare con i leader dei partiti europei e/o dei gruppi politici).
Il candidato-designato deve essere poi “eletto” a maggioranza assoluta (376 deputati) dal Parlamento europeo e, ottenuto questo consenso, partecipa con il Consiglio alla formazione dell’intera Commissione (“il Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che esso propone di nominare membri della Commissione”) e si sottopone infine all’approvazione del Parlamento europeo (a maggioranza semplice) prima della nomina finale sempre a maggioranza qualificata da parte del Consiglio europeo.
Nonostante i passi in avanti con il voto a maggioranza qualificata nel Consiglio europeo nel tentativo di evitare il rigetto da parte dei paesi euroscettici di candidati “federalisti” (nel 1995 con il lussemburghese Santer preferito al belga Dehaene o nel 2004 con il portoghese Barroso preferito al belga Verhofstadt in entrambi i casi per il veto britannico) e con l’elezione del Presidente da parte del Parlamento europeo, la procedura prevista a Lisbona è molto farraginosa, poco trasparente e sottoposta sia al rischio di uno scontro di potere fra governi e Parlamento sia all’obbligo di larghe intese all’interno dell’Assemblea riducendone il dinamismo politico.
Sulla base del risultato delle elezioni del 22-25 maggio, l’ipotesi prevalente per l’elezione del Presidente è quella di una grande coalizione fra popolari e socialisti allargata ai liberali nella quale convergerebbero i due terzi dell’assemblea lasciando all’opposizione verdi e sinistra oltre a tutti i movimenti euroscettici. Tutte le altre coalizioni sono o matematicamente escluse come quella cosiddetta “semaforo” (socialisti-verdi-liberali-sinistra) o politicamente impraticabili come quella cosiddetta “Giamaica” (ppe-liberali-gruppi conservatori ed euroscettici.)
Allo scopo di rafforzare la dimensione politica delle elezioni europee, di contribuire a creare uno spazio pubblico europeo e, in definitiva, di parlamentarizzare la vita democratica dell’Unione, i maggiori partiti politici europei hanno deciso l’uno dopo l’altro di designare un loro candidato alla presidenza della Commissione pretendendo unilateralmente (e cioè senza un accordo preliminare con i governi) di imporre il principio secondo cui il Consiglio europeo sarebbe politicamente tenuto a designare il candidato del partito o della coalizione di partiti vincente.
Cosicché i socialisti con il voto contrario dei laburisti britannici hanno accettato l’autocandidatura di Martin Schulz, i liberali hanno preferito il belga Verhofstadt al finlandese Rehn, i verdi hanno scelto con una consultazione on-line il francese Bové e la tedesca Keller, la Sinistra Unitaria Europea ha approvato l’autocandidatura del greco Tsipras e i popolari hanno infine deciso di entrare nel gioco delle candidature preferendo il lussemburghese Juncker al francese Barnier ma con un voto contrastato dove le astensioni sono state più numerose dei voti espressi.
“Una falsa buona idea ?” aveva scritto, preveggente, Le Monde quando Martin Schulz aveva annunciato la sua autocandidatura. E, in effetti, la decisione dei partiti europei si è scontrata con una serie di ostacoli che ne hanno indebolito l’effetto e hanno acuito, invece di ridurle, le tensioni fra le istituzioni.
In primo luogo, l’Unione non è (ancora) una democrazia parlamentare sovranazionale ma è fondata sulla doppia legittimità nazionale (il Consiglio europeo e il Consiglio) ed europea (il Parlamento europeo) che rimarrà a lungo una costante di un sistema di federalismo sui generis cui si sono successivamente ispirati il Parlamento europeo con il progetto Spinelli, la Convenzione sulla costituzione europea e il Trattato di Lisbona.
L’indicazione delle candidature alla presidenza della Commissione, come succedanea dell’elezione diretta, ha un impatto modesto in assenza di una legge elettorale uniforme e di veri partiti europei ostacolando l’indispensabile dinamismo politico per ricercare coese maggioranze politiche da costruire innanzitutto intorno a programmi e agende condivise.
In secondo luogo e in assenza di programmi di governo per la legislatura fondati su visioni anche radicalmente diverse legate a politiche economiche e sociali e al significato della democrazia europea, la campagna elettorale europea è stata largamente assorbita – nella maggioranza dei paesi membri – da dibattiti di dimensione nazionale facendo evaporare l’auspicato effetto di creare uno spazio pubblico europeo.
A ciò ha contribuito anche il fatto che rari sono stati i partiti nazionali che hanno spiegato agli elettori il collegamento fra le scelte nazionali e quelle europee, la scarsa partecipazione delle opinioni pubbliche nazionali ai tre dibattiti televisivi fra i candidati e il diffuso disinteresse dei giovani per questa dimensione di democrazia formale.
In terzo e ultimo luogo gli elettori hanno lanciato al mondo della politica e alle istituzioni europee segnali inequivocabili della loro volontà di invertire la rotta, un segnale di protesta da prendere in seria considerazione molto più dell’apparente scelta di questo o quel candidato alla presidenza della Commissione.
Tale protesta si è espressa in forme diverse (il 57 % delle astensioni, la crescita dei movimenti euroscettici in dodici paesi membri con punte elevate in Francia e Regno Unito, la sconfitta della maggioranza dei partiti di governo..) contro le politiche di rigore adottate in questi anni, gli effetti disastrosi di tali politiche sul piano sociale, l’assenza di azioni europee efficaci per l’immigrazione e per la lotta al crimine e alla corruzione
Gli elettori si allontaneranno ancor di più dal progetto europeo se non saranno date risposte concrete sul piano di beni comuni che non possono essere garantiti a livello europeo piuttosto che nel prevalere dei partiti europei sui governi per la scelta del presidente della Commissione.
Se si esamina poi la natura delle proteste, ci si rende conto che l’effetto mediatico della vittoria dei movimenti populisti ed euro-ostili in Francia, nel Regno Unito e in Danimarca è largamente compensato dalla loro sconfitta in Belgio, in Bulgaria, in Finlandia, nei Paesi Bassi e in Slovacchia, dalla vittoria degli europeisti nei paesi baltici, in Croazia, nella Repubblica Ceca, dalla tenuta dei partiti tradizionali in Austria, in Polonia, in Portogallo e in Romania, dalla vittoria dei partiti di governo in Germania e in Italia, la sostanziale assenza di partiti eur0-ostili in Spagna.
A questo risultato si aggiunge la crescita dei votanti in un paese colpito come la Grecia dove l’inquietante avanzata del movimento neo-nazista Alba Dorata è stata compensata dalla vittoria della sinistra radicale Syriza, pro europea se non federalista.
La nomina della nuova Commissione coincide con il rinnovo delle altre leadership istituzionali: presidente del Consiglio europeo, alto rappresentante della politica estera, probabilmente presidente dell’Eurogruppo. Se tutta la procedura di rinnovo della Commissione si concludesse entro la fine dì settembre, la presidenza italiana potrebbe suggerire di anticipare la scadenza del rinnovo delle istituzioni al 1° ottobre 2014 in modo tale da assicurare rapidamente il funzionamento del sistema già in occasione del Consiglio europeo di fine ottobre. Ciò richiederebbe le dimissioni anticipate della Commissione Barroso, del presidente del Consiglio europeo e dell’alto rappresentante della politica estera.
Questo complesso funzionamento del sistema costruito a Lisbona sarà messo a dura prova dagli effetti del risultato delle elezioni europee del 22-25 maggio. A cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato, la presidenza italiana del Consiglio dell’Unione, accogliendo un suggerimento del Movimento Europeo, ha deciso di avviare una riflessione fra i governi fondandola su tre elementi: il funzionamento del sistema, le relazioni triangolari Parlamento-Consiglio-Commissione, la prospettiva dell’Unione politica così com’era stata delineata dal rapporto dei quattro presidenti sul completamento dell’unione economica e monetaria.
Il governo italiano è cosciente della difficoltà di un esercizio limitato alla sola dimensione intergovernativa. Allo stato attuale, solo il governo britannico si è pronunciato a favore di una modifica del Trattato allo scopo di “rimpatriare” competenze attribuite all’Unione europea, un esercizio periglioso cui si è inizialmente associato solo il governo olandese.
L’azione del governo potrebbe essere ostacolata dal fatto che il risultato elettorale ha reso ancora più complicate le relazioni franco-tedesche con il mondo politico francese sotto lo choc della vittoria del Fronte Nazionale e la Germania alla ricerca di un equilibrio all’interno della grande coalizione fra CDU e SPD.
I sintomi di un divorzio nella coppia franco-tedesca hanno del resto radici più lontane nel tempo: dopo essere stato fondata a lungo sull’egemonia e la capacità di iniziativa francese in particolare in politica estera, essi hanno cominciato a manifestarsi dopo l’unificazione tedesca e si sono acuiti con la crisi finanziaria quando l’egemonia è stata assunta con forza dalla cancelliera Merkel e la governance economica dell’Europa ha funzionato al ritmo imposto dalla Germania.
La crisi del direttorio potrebbe tuttavia offrire al governo italiano – confortato come quello tedesco dal voto del 25 maggio – il terreno di un’azione convergente fra Roma e Berlino, ambedue interessante a verificare in che misura l’eurozona potrebbe essere la dimensione ottimale per rilanciare il processo verso una maggiore unione politica partendo dalle due integrazioni rimaste in sospeso dopo la realizzazione dell’unione bancaria: l’unione fiscale e l’unione economica.
Le occasioni di un confronto costruttivo non mancano se si pensa all’interesse tedesco per il rafforzamento della legittimità democratica dell’Unione europea, agli spazi di manovra economica introdotti dall’entrata in vigore della tassa sulle transazioni finanziarie, dall’urgenza di politiche di lotta alla disoccupazione in particolare giovanile, dall’imminente riapertura del dibattito sul bilancio europeo con le proposte del gruppo di lavoro presieduto da Mario Monti sulle ris9rse proprie e, sullo sfondo, la revisione a medio termine nel 2016 delle prospettive pluriennali.
Nella riflessione sull’avvenire dell’Europa non può tuttavia mancare il tassello della politica estera reso più urgente dalle tensioni provocate dalla crisi ucraina dove agli aspetti politici si accompagna anche la dimensione economica della sicurezza energetica. Anche su questo terreno, Roma e Berlino si sono mosse in modo convergente.
Alla vigilia delle elezioni europee è emersa con forza, in Italia e in Germania, la volontà del mondo economico e dei sindacati di riprendere la strada dell’unificazione politica su basi federali. Nel Parlamento europeo e all’interno delle coalizioni di governo ci sono oggi le condizioni per assumere una forte iniziativa politica italo-tedesca per andare al di là di Lisbona. E’ questa la risposta più efficace che Italia e Germania possono dare ai segnali di protesta che sono stati espressi nel risultato elettorale del 25 maggio.
Pier Virgilio Dastoli (presidente del Movimento europeo-Italia, membro del board del Gruppo Spinelli)